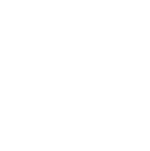Episodio 9 | Katia Scotlandi – Ricerca oncologica
Fare ricerca è percorso difficile e faticoso, che richiede nervi saldi. Spesso ci si deve confrontare con il fallimento, con la disillusione o con un successo che, anche quando ripaga degli enormi sforzi compiuti, non è mai immediato. Ma fare ricerca in medicina è un lavoro bellissimo e indispensabile che non conosciamo mai abbastanza. Per farsene un’idea basta ascoltare testimonianze come quella della professoressa Katia Scotlandi, che dirige il Laboratorio di Oncologia sperimentale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, e coordina il Centro di riferimento “Sviluppo di terapie biomolecolari”. Da molto tempo al centro del suo interesse ci sono gli osteosarcomi: tumori ossei che in Italia riguardano appena 100 nuovi casi ogni anno, ma pur essendo relativamente rari hanno un impatto umano e sociale altissimo. Anzi, insopportabile. Gli osteosarcomi infatti colpiscono soprattutto i bambini e gli adolescenti, ecco perché bisogna combatterli con forza e con tutte le armi della ricerca. Come fa la professoressa Scotlandi da 30 anni.
Trascrizione
Specialmente Pubblici Episodio 9 | Katia Scotlandi – Ricerca oncologica
C'è un esercito invisibile e numeroso che combatte in silenzio in ogni angolo del mondo, con metodo e costanza. Il suo scopo non è vincere l'intera guerra – non sarebbe possibile – ma conquistare poco a poco terreno, avere la meglio battaglia su battaglia. Non per sconfiggere il nemico che è invincibile, ma per allontanarlo e mettere distanza tra lui e l'umanità intera. È il solo esercito a meritare sempre l'onore delle armi. Non c'è la vergogna del campo di battaglia, perché la guerra che si porta avanti qui è nobile, ed è la sola a non essere sciagura umana. Stiamo parlando della lotta contro la morte e la malattia di medici e ricercatori per scoprire, ad esempio, come diagnosticare precocemente i tumori, come prevedere il loro comportamento, come contrastarli più efficacemente e con minori effetti collaterali. È la grande battaglia della ricerca, che si combatte anche all'Istituto ortopedico Rizzoli da più di 30 anni.
Specialmente Pubblici è la seconda serie del podcast prodotto da Regione Emilia-Romagna per rafforzare la consapevolezza che il servizio sanitario nazionale e quello regionale sono un patrimonio collettivo di grandissimo valore. Un patrimonio fatto di specializzazioni, di équipe e persone che si distinguono anche per riconoscimenti conseguiti in Italia e all'estero. Donne e uomini che hanno scelto di compiere ogni giorno un passo in avanti per continuare a garantire le migliori cure a tutti, nessuno escluso.
La professoressa Katia Scotlandi dirige il Laboratorio di Oncologia sperimentale dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, dove coordina anche il Centro di riferimento “Sviluppo di terapie bio-molecolari”. In altre parole, fa ricerca di altissima specializzazione in un luogo per questo rinomato nel mondo. Ma che luogo è oggi la sanità pubblica?
Katia Scotlandi, responsabile del Laboratorio di Ricerca oncologica dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna – La sanità pubblica per me è il luogo dove si trova l'eccellenza. Non c'è eccellenza in un sistema che non sia pubblico, che renda accessibile e giusta la cura alle persone; ma anche un luogo che sappia accogliere la complessità dei trattamenti e la complessità della malattia. Quindi è un luogo di cui essere sicuramente orgogliosi.
La storia professionale di Katia Scotlandi, biologa, coincide con quella dell'area dedicata alla ricerca dell'Istituto Rizzoli, che lei ha contribuito a sviluppare.
Scotlandi – Io sono arrivata a Rizzoli negli anni '90, quando l'Istituto ortopedico Rizzoli ha iniziato la sua attività di ricerca, ha aperto in quegli anni il laboratorio di ricerca. Quindi mi sono trovata giovane biologa appena laureata e specializzata, in una dimensione molto particolare, perché l'istituto era già molto famoso e molto noto nel mondo per quello che riguardava la ricerca clinica e la cura clinica dei pazienti; mentre era tutto da iniziare, tutto da fare, per quello che riguardava, invece, il settore della ricerca. Quindi è stato un momento molto molto appassionante, a mio avviso anche unico quasi nel panorama italiano – o internazionale – perché comunque ci siamo trovati con spazi e tutto da costruire. E quindi questo, per quello che mi riguarda, ha sicuramente creato un rapporto molto speciale con questo Istituto, a cui obiettivamente ho dedicato tutta la mia attività scientifica e la mia vita professionale, perché ormai sono passati 30 anni e sono ancora lì.
Tra i recenti successi del laboratorio di Oncologia sperimentale del Rizzoli, ce n'è uno che risale al maggio scorso e riguarda un nuovo tipo di immunoterapia.
(applausi, una voce femminile tiene un discorso)
Cari colleghi, la University College di Londra e il Rizzoli di Bologna hanno condotto insieme la ricerca su una nuova immunoterapia contro i sarcomi ossei. La sperimentazione preclinica del trattamento messo a punto col Laboratorio di oncologia Sperimentale del Rizzoli, diretto dalla professoressa Katia Scotlandi, ha avuto successo e questa è una bellissima notizia per tutta la comunità scientifica…
(gli applausi aumentano)
…ma soprattutto per i giovani pazienti che nutrono grandi attese.
Gli osteosarcomi sono al centro dell'interesse della professoressa Scotlandi da molto tempo. Sono tumori ossei che riguardano appena 100, 120 nuovi casi ogni anno in Italia. Eppure la ricerca in questo campo sembra essere molto importante.
Scotlandi – I sarcomi sono una patologia molto eterogenea, relativamente rara, che colpisce – nel caso specifico dei sarcomi delle ossa – soprattutto i bambini e gli adolescenti, e quindi sono una patologia che, pur nella sua relativa rarità, ha un grande impatto sociale.
L'osteosarcoma è un tumore difficile da affrontare. Nonostante i progressi, il trattamento sistemico è ancora legato all'uso di chemioterapici tradizionali. Per i pazienti che non reagiscono a questa terapia sono necessari nuovi approcci, ed è per questo che lo studio compiuto dal Rizzoli con i ricercatori inglesi è molto importante. Inoltre, ci fa capire che alla base di ogni progetto di ricerca c'è una visione, che il più delle volte fa la differenza. E al Rizzoli “visione” è sempre stata la parola chiave.
Scotlandi – L'istituto era già, come dicevo, molto famoso allora, quando io ho iniziato e – questo lo dico spesso – era già allora un Istituto che aveva una grande visione. Era grazie alla visione appunto del fondatore, il professore Mario Campanacci. L'istituto era Centro di riferimento ed è tuttora ovviamente uno dei centri di riferimento per il trattamento e la cura di questi tumori, che sono tumori delle ossa e che necessitano di un approccio complesso e multidisciplinare. Oggi questa parola – “approccio multidisciplinare” – va molto di moda ed è una parola assolutamente attuale, ma nel 1990 era obiettivamente una parola quasi avveniristica. Quindi il trattamento di questi pazienti, la centralità del paziente rispetto, appunto, ai percorsi di cura è sempre stata una caratteristica dell'Istituto e questo ha allenato anche me, che faccio invece un lavoro di ricerca, ad una interazione molto diretta, molto concreta con i colleghi chirurghi piuttosto che oncologi, piuttosto che anatomopatologi, piuttosto che radiologi. E questa sicuramente è stata una grande opportunità di crescita e anche una grande opportunità di trasferire quello che è un lavoro soprattutto intellettuale, in cui c'è un percorso ovviamente di studio, in cui ci sono domande che sono domande a volte teoriche, però, ecco, di fare lo sforzo di trasferire queste domande in un contesto molto pratico e di combinare quello che è la conoscenza con le necessità: la conoscenza del ricercatore, la necessità del paziente dall'altro.
Fare ricerca è percorso difficile, faticoso, e richiede nervi saldi. Spesso ci si deve confrontare con il fallimento, con la disillusione o con un successo che, anche quando ripaga degli enormi sforzi compiuti, non è mai immediato.
Scotlandi – Spesso è un percorso fatto di pochi successi, molte frustrazioni, è un percorso in cui raramente si riesce a mettere un punto e ad andare a capo. Quasi sempre sono dei punti che, ehm… dei punti e virgola più che dei punti, perché poi da ogni piccola conclusione, da ogni piccolo passo, si generano ulteriori domande, ulteriori necessità di andare avanti. È però un lavoro che per me è stata la mia passione di vita. Io questo lo dico sempre, per fare ricerca bene, per farla ad alto livello, bisogna avere soprattutto un fuoco dentro, una passione dentro che ti muove.
Oggi in medicina si parla spesso di crisi delle vocazioni. Eppure, la vostra pagina Facebook è piena di foto di gruppo di camici bianchi giovani, o addirittura giovanissimi.
Scotlandi – È un lavoro a mio avviso molto interessante, anche per i giovani, perché è un lavoro che costringe a crescere non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. Costringe tutti i giorni a trovare strade nuove, costringe a lavorare all'interno di una complessità, cercando di non spaventarsi per questa complessità e di cercare invece soluzioni a questa complessità. E in questo percorso – che sicuramente è faticoso, difficile e, a volte, inevitabilmente frustrante – però ci sono degli spazi di luce, quando uno riesce a trovare il risultato giusto, a trovare qualcosa che davvero può servire al paziente, a trovare qualcosa che davvero possa alimentare la speranza del paziente. Ecco, questi punti di luce spesso ripagano di tutta quella che è stata la fatica fino a quel momento. E questo credo sia il compito della ricerca, della ricerca dentro a un IRCCS, quindi dentro a un Istituto che è un'eccellenza, perché appunto il nostro compito come ricercatori è soprattutto quello di guardare non all'oggi ma al domani, di creare un ponte con il domani e alimentare la speranza per i pazienti, ma anche quello che, appunto, poi verrà trasferito alla realtà clinica nel giro di qualche anno. Questo ritengo che sia una ricerca di successo dentro un Istituto a carattere scientifico che ha comunque una declinazione traslazionale molto forte.
L'IRCCS Rizzoli è una struttura pubblica. Cosa significa partecipare a gruppi di ricerca internazionali con uno statuto che a volte, immagino, può rivelarsi vincolante per chi opera in un campo affollato da soggetti molto eterogenei?
Scotlandi – La ricerca ha inevitabilmente anche un respiro internazionale, quindi la competizione non è mai solo a livello metropolitano, a livello regionale o a livello nazionale, ma è spesso con gli altri gruppi di ricerca che lavorano nel settore a livello internazionale. E questo ovviamente è un altro punto di difficoltà e anche ovviamente di soddisfazione. Declinare tutto questo in un ambito pubblico, dentro a un servizio sanitario nazionale, vuol dire anche poi farsi carico di quelle che sono le responsabilità di ricerche che devono trovare anche una sostenibilità economica. Questo è un altro punto sicuramente molto importante e molto attuale che rappresenta, di nuovo, un’ulteriore sfida a cui noi siamo tutti i giorni chiamati a dare una risposta.
C'è un episodio in particolare, un'avventura scientifica, una piccola conquista che ha visto applicata sul campo e vuole raccontarci?
Scotlandi – Le conquiste ci sono state, ovviamente, in tutto questo percorso di 30 anni, dei momenti di grande soddisfazione che sono andati anche oltre la pubblicazione scientifica, che ovviamente per un ricercatore è sempre uno degli obiettivi. Però credo che dentro un IRCCS pubblico sia importante la pubblicazione, ma sia importante anche vedere il trasferimento della propria attività in qualcosa di concreto che possa incidere realmente nel miglioramento del trattamento di cura di un paziente. Questo obiettivamente capita poche volte nella vita di un ricercatore, nel mio caso è capitato direi un paio di volte. Una, la prima, è capitata molti anni fa in termini di ricerca, di risultato: nel 1995 – quindi davvero molti anni fa – abbiamo pubblicato su una rivista molto prestigiosa – il New England Journal of Medicine – il valore di un biomarcatore come fattore di prognosi; quindi pazienti il cui tumore esprimeva o non esprimeva questa molecola avevano un rischio diverso di progressione della malattia. Ci sono voluti 15 anni affinché la comunità scientifica e i colleghi clinici, eccetera, potessero veramente considerare valido questo risultato – perché obiettivamente di biomarcatori ce ne sono tanti –, però dopo questo biomarcatore è stato utilizzato in un nuovo trial clinico, quindi in un trattamento e in un protocollo clinico basato proprio sulla valutazione di questo biomarcatore al momento della diagnosi del paziente.
Traguardi davvero importanti… ovviamente il trasferimento dei risultati dalla ricerca alla clinica è sempre molto complesso, perché gli attori coinvolti sono tanti, compresi gli enti finanziatori e l'industria farmaceutica. Ci vuole indicare altri ambiti di ricerca in cui siete impegnati?
Scotlandi – Abbiamo operato tantissimo negli ultimi anni a identificare invece dei bersagli terapeutici… In questo siamo stati uno dei primi gruppi italiani che ha identificato un recettore per il sistema insulino-simile che obiettivamente ha portato allo sviluppo poi di anticorpi e di molecole che sono state utilizzate e che hanno portato in un sottogruppo di pazienti anche a degli ottimi risultati.
Cosa rappresenta per lei la sanità pubblica lo ha già detto. C'è qualcosa che vuole aggiungere?
Scotlandi – Il nostro sistema sanitario è uno dei sistemi migliori al mondo, lo si legge spesso sui giornali, però questo vale perché nella quotidianità poi vengono fatte costantemente delle scelte e quindi è importante conoscerne l'origine, conoscerne l'attualità e anche operare le giuste scelte in un sistema obiettivamente complesso come quello attuale.
Specialmente Pubblici è un podcast prodotto da Regione Emilia-Romagna. Direzione artistica e voce narrante sono di Mimma Nocelli. Il progetto editoriale è di Homina Comunicazione. Postproduzione e sound design sono di Fonoprint.