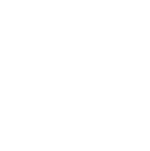Calcolo ergo Sum - Emilia-Romagna Data Valley
La scoperta dell’acqua su Marte. Il salvataggio da una terribile tempesta delle ciliegie di Vignola. La realizzazione del gemello digitale della città di Bologna. La creazione della libreria europea per l’analisi delle immagini mediche. La conquista del titolo mondiale del pilota Ducati Francesco Bagnaia. C’è un denominatore comune a tutto questo? Sì: l’Emilia-Romagna piattaforma europea dell’innovazione e del digitale. Calcolo ergo sum – la Data Valley dell’Emilia-Romagna è il titolo di questa puntata che contiene le testimonianze del presidente del Cineca, Francesco Ubertini, il professore di filosofia ed etica dell’informazione all’Università di Oxford, Luciano Floridi, la professoressa del dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Rita Cucchiara, e il responsabile analisi dati del reparto Ducati Corse, David Attisano.
Trascrizione
[VOCE NARRANTE]
Ok Google, che cos'è il supercomputer Leonardo?
[Google]
Leonardo è uno degli 8 supercomputer pre-exascale che formeranno la rete di calcolo europea ad alte prestazioni euro HPC e verrà realizzato in Italia presso il Tecnopolo di Bologna.
[VOCE NARRANTE]
Mi dispiace contraddirti Google, ma il supercomputer Leonardo è già da mesi che è arrivato al Tecnopolo di Bologna, nell'area di 100.000 m² dell'ex manifattura Tabacchi. È arrivato a bordo di 30 autoarticolati. Pensa che gli ingegneri hanno dovuto realizzare apposta un pavimento super rinforzato perché pesa come 700 persone assieme; nei 10 km di tubazioni scorre già acqua fresca e refrigerata.
Nel suo cervello pulsano processori artificiali e nelle vene scorre un'enormità di algoritmi, giorno e notte in Emilia-Romagna, che è - anche grazie a lui - la capitale europea dei dati.
Ti racconto l’Emilia-Romagna è il podcast a cura dell'Agenzia di informazione e comunicazione della Regione. Calcolo ergo sum, la data Valley dell’Emilia-Romagna.
[VOCE NARRANTE]
La capitale dei big data, dell'intelligenza artificiale, del super calcolo non si costruisce in un giorno. Se oggi è un luogo fisico e un ecosistema al servizio del paese, dell'Europa, c'è dietro un lavoro di persone, ricerca e macchine che va avanti da decenni. CDC 6600 e Marconi 100 solo per menzionarne due, sono super calcolatori che vengono prima di Leonardo, gestiti sempre dai ricercatori del Cineca, il consorzio universitario per il calcolo automatico formato da 112 enti pubblici.
È anche grazie a questi cervelloni se è stata scoperta l'acqua su Marte, se si è riusciti ad analizzare ogni singolo fotogramma dell'incidente che costò la vita ad Ayrton Senna, se si sono salvate in tempo le ciliegie di Vignola prevedendo una terribile gelata. Sempre qui si è contribuito alla ricerca sulle molecole farmaceutiche che sono alla base dei vaccini contro il coronavirus. E adesso è arrivato Leonardo, il quarto super calcolatore più potente al mondo. Siamo con il Presidente del Cineca, Francesco Ubertini. Quali sono i superpoteri del pre-exascale Leonardo?
[Francesco Ubertini]
Se noi consideriamo tutti gli abitanti della terra, gli chiediamo di fare una somma ogni secondo per 365 giorni, alla fine avranno sviluppato una potenza di calcolo complessiva che Leonardo sviluppa in un secondo.
[VOCE NARRANTE]
Dietro a Leonardo lavora un team di 150 ricercatori. Il 50% della potenza di calcolo generata sarà a disposizione degli istituti di ricerca e dell'università italiane, il resto sarà utilizzato dai ricercatori europei. Concretamente, ci dice un progetto a cui sta lavorando Leonardo?
[Francesco Ubertini]
Un esempio su tutti sui quali si sta lavorando con la Regione, la Città metropolitana, è quello di sviluppare “Gemelli digitali” sulla qualità dell'aria su scala regionale, dove diciamo questo significa non solo avere un modello che permette di fare delle previsioni, ma anche elaborare scenari, impatto di politiche attive, supporto alle decisioni e, in ultima istanza, miglioramento dei servizi ai cittadini e alle cittadine.
Leonardo è Leonardo da Vinci. È appena entrato in funzione ma noi stiamo già lavorando per la sua espansione che avverrà nel giro di un anno e mezzo, due al massimo, diciamo un anno e mezzo. E sempre per rimanere in tema, l'espansione si chiamerà Lisa come Monna Lisa.
[VOCE NARRANTE]
Di fianco al data center del Cineca, al Tecnopolo di Bologna abitano anche la sede del Centro europeo che fa previsioni climatiche, il data center dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, che processa i dati che vengono dal Cern di Ginevra e molto altro. Questo hub europeo dei big data e del digitale concentrerà oltre 80% della capacità di supercalcolo nazionale, il 20% di quella europea, con applicazioni pratiche in tutti i settori: transizione ecologica e lotta ai cambiamenti climatici, transizione digitale, sanità, tempi delle città e logistica, imprese e processi produttivi sostenibili, agricoltura.
E le cittadine e i cittadini dell’Emilia-Romagna se ne accorgono o se ne accorgeranno di abitare nella Data Valley. Lo chiediamo a Luciano Floridi, che è membro del comitato scientifico della Fondazione Leonardo e professore ordinario di Filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford.
[Luciano Floridi]
Ma la speranza è che non se ne accorgano. Cioè che tutto funzioni talmente bene e talmente meglio che è come se non ci fosse. Lei immagini, appunto, qual è il vantaggio di avere acqua potabile, aria pulita, una città in cui non c'è traffico, non te ne accorgi. Per fare un esempio concreto, il traffico è migliorato tantissimo. Ecco, pian piano ti abitui e a un certo punto, il fatto che dietro ci siano, ad esempio, modellizzazioni, simulazioni che hanno permesso di migliorare il traffico, di pulire al meglio l'aria, di rendere l'acqua sempre più non solo potabile ma anche piacevole averla, ma anche la possibilità di trovare lavoro più facilmente, di operare in o attraverso l’amministrazione in maniera elementare, di non correre rischi, cioè cose che non sono successe e quindi non me ne accorgo. E così via tutto questo. E ha dietro enormi quantità di dati, grande potenza, grande potenza di computazioni. Con me è una competenza umana. E dicevo appunto, paradossalmente tanto meglio vanno le cose, tanto meno me ne accorgo. Ecco, se un giorno noi arrivassimo a dire ‘guarda veramente è come se non ci fosse’ ecco, secondo me quello è successo.
[VOCE NARRANTE]
La Data Valley non è solo Bologna, qui si concentra una competenza di ricercatrici, ricercatori e macchine che coinvolge l'intera rete di tecnopoli regionale, le università, i centri di ricerca. Per quanto riguarda l'analisi dei dati, l'apprendimento automatico e il machine learning, per esempio, andiamo all'Università di Modena.
[VOCE NARRANTE]
Ok Google, Chi è Rita Cucchiara?
[Google]
Rita Cucchiara è un ingegnere elettrico e informatico italiano e professore di architettura, informatica e computer vision presso il dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia in Italia.
[VOCE NARRANTE]
Professoressa Cucchiara ci fa un esempio di qualche progetto che riguarda i laboratori di Modena.
[Rita Cucchiara]
Noi in questo momento abbiamo dei grossi progetti europei sulla salute e ne cito due, uno che si chiama DeepHealth che ha creato le librerie per il Medical Images, per analisi di immagini mediche che poi vengono utilizzate a livello europeo, ed un altro appena iniziato dalla mia collega Elisa Ficarra che si chiama Decider e che si occupa del tumore all'utero a livello europeo. Per cercare dei modelli predittivi ma anche spiegabili, quindi non soltanto, insomma. delle scatole nere magiche sul fatto che si può predire questo grossissimo problema. Quale? Il tumore è nell'ambito femminile di dati che in realtà a livello europeo si stanno raccogliendo e che il nostro Centro Modena è l'unico in Europa che si occupa effettivamente della parte di machine learning a livello informatico.
[VOCE NARRANTE]
Ma anche intelligenza artificiale nelle aziende…
[Rita Cucchiara]
Le aziende sono molto contente di collaborare con noi. Faccio tre esempi, Tetrapak, Florim e Ima. Giusto per dire, le grandi aziende che conosciamo. Con Ima abbiamo ormai terminato un progetto europeo che loro avevano iniziato e su cui siam stati sub contractor per fare delle analisi predittive di funzionamento e dei guasti e con dei risultati che credo che per loro siano stati di grande successo. Con Tetrapak è da diversi anni che stiamo lavorando, Tetrapak ha avuto una grande lungimiranza nell'acquisire, nel raccogliere dati da tempi non sospetti e quindi, per esempio, con loro stiamo facendo l'analisi della postura, dei lavoratori per salvaguardare il loro, diciamo, la loro vita normale nel momento in cui interagiscono con i macchinari, quindi stiamo facendo analisi ergonomiche delle macchine. Con Florim abbiamo iniziato ora un lavoro molto intenso sulla ottimizzazione della produzione nei nuovi impianti che si stanno realizzando per acquisire i dati che vengono da tutti i sensori, da IOT del dell'azienda dei robot mobili, ma anche per studiare nuovi modelli di progettazione di ceramica, soprattutto con reti neurali assolutamente innovative, per dare una mano ai designer nella generazione di questi dati.
[VOCE NARRANTE]
“Non guardare il computer ascolta me”. Erano i primi anni 2000 quando l'ex campione del mondo australiano Casey Stoner si indispettiva quando l'ingegnere della Ducati cercava conferma voltando lo sguardo verso lo schermo con i dati. Davide Attisano è il responsabile analisi dati del reparto Ducati Corse, all'inizio tutta quella elettronica non andava mica tanto giù ai piloti, poi hanno cambiato idea?
[Davide Attisano]
Quando è arrivato da noi Casey Stoner eravamo molto avanti su tutta una serie di tentativi di fare simulazioni, di fare delle previsioni, per esempio del consumo, che era un tema molto, molto caldo all'epoca, no? Perché si era passati al motore 1000 da un motore 800. Erano state introdotte tutta una serie di indicazioni che facevano sì che il carburante non bastasse, in realtà per finire la gara e bisognava ingegnarci appunto a cercare di far finire la gara ai piloti. È successo in diverse occasioni che abbiamo costretto i piloti a utilizzare delle mappe motore che loro odiavano, che detestavano per poter finire la gara e in particolare c'era sia Casey che Loris Capirossi, che all'epoca si lamentava di questa cosa. Però mi ricordo anche che la prima gara in Qatar nel 2007, senza questo non avremmo tagliato la linea del traguardo.
[VOCE NARRANTE]
Che concretamente, come si traducono le informazioni sulle sospensioni, sui motori, sulle ruote, in numeri, in algoritmi?
[Davide Attisano]
Le moto che girano in pista sono equipaggiate con tutta una serie di sensori a bordo, prendiamo dei parametri che secondo noi sono identificativi del fatto che la moto possa girare. E li etichettiamo come eventuale comportamento positivo o negativo in quella curva, secondo appunto il giudizio del pilota. E con questa tecnica uno può provare ad allenare un algoritmo che ti dica in quali curve effettivamente il dato che tu hai corrisponde con quello che è stato il giudizio del pilota, in quali altre curve magari non corrisponde e in quali altre magari il pilota in quel momento non ce l'ha ricordato perché comunque sulla moto lui deve pensare a sopravvivere, soprattutto e a fare la prestazione massima possibile. Magari alcune curve lui non ti ha detto nulla e tu vedi delle cose nei dati che l'algoritmo ti suggerisce essere potenziali prestazioni buone o potenziali prestazioni non altrettanto buone.
[VOCE NARRANTE]
La casa di Borgo Panigale ha appena festeggiato un'annata straordinaria con i titoli iridati di Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista. Che percentuale avete voi ingegneri, l'intelligenza artificiale in questi successi?
[Davide Attisano]
È una domanda da un milione di dollari, eh, nel senso che a noi piace pensare che il nostro contributo sia fondamentale, quindi, che sia oltre quell'1% che fa la differenza in pista, no? Dare una quantificazione è complicato perché non c'è una percentuale, no? Alla fine poi basta un errore del pilota, o una giornata storta o cade la pioggia e noi non avevamo pensato a quelle condizioni là, che vanifica tutti gli sforzi, quindi. Nel reparto? Forse ti direi che tutti sono fondamentali e nessuno è fondamentale. E se salta un solo anello della catena è possibile che la prestazione non si riesca a farla… A volte ti gira tutto bene e invece anche se magari qualche cosa non è perfetta e in quella giornata lì, il pilota in stato di grazia e riesce a fare la differenza da solo.
[VOCE NARRANTE]
Più le tecnologie sono potenti, più però esiste un rischio, quello che diventino uno strumento pericoloso, pensiamo alla cybersicurezza, alle frodi, all'uso in ambito bellico, alle analisi dei dati che generano fake news e false aspettative nell'opinione pubblica. Professor Floridi, non è sempre vero che il digitale è una forza buona…
[Luciano Floridi]
In gran parte il digitale è una forza buona, cioè è una di quelle cose che l'umanità ha creato per vivere meglio, per fare meno quello che non vogliamo fare, per fare di più di quello che vogliamo fare e per fare diversamente quello che già stiamo facendo. Con il digitale si corre in discesa, si corre in maniera molto facile. Ci vuole veramente un po’ di perversione a trasformarlo in un problema. Purtroppo, l'umanità è famosa per la sua perversione e quindi su questo non sarei troppo ottimista. Faremo grandi danni. Noi abbiamo già da anni aziende che sfruttano tutto questo, on-line, ad esempio per creare siti in cui, ad esempio, i genitori possono andare e ricordare un bambino morto. Lo fanno in modo tale da forzare, invitare addirittura a tornare a mettere cose su quel sito, a spendere tempo e denaro per celebrare il bambino che non c'è più. Ecco, questo è pericolosissimo. Vuol dire sfruttare l'emotività, l'intelligenza umana, per fini veramente negativi. Ma ci vuole l'intenzionalità umana per farli. Ci vuole, se vuole, posso, in termini molto semplici, ci vuole un progetto per far sì che questo digitale faccia veramente male a tutti, e a tutte. Ecco, su questo io insisterei., perché con un po’ di buona legislazione e dovremmo farcela.
[Rita Cucchiara]
Certamente tutto questo va regolato e per fortuna siamo in Europa e non siamo in altre parti del mondo dove la regolazione dell'intelligenza artificiale è un must importante, dove sta uscendo lo AI Act che proprio ci permetterà di regolare l'intelligenza artificiale negli ambiti a rischio ad alto rischio, come possono essere quelli per esempio che riguardano la nostra salute, l'educazione dei nostri figli, uno tutto quello che riguarda la privacy della singola persona.
[VOCE NARRANTE]
Nel 2013 il regista americano Spike Jones realizza il film Her: Lei. È la storia di un uomo, Theodor, che si innamora di Samantha, che però non è una persona vera, è una voce, la voce del suo sistema operativo. Samantha è in grado di capirlo meglio di chiunque altro, lo conquista proprio perché lo capisce perfettamente. Professor Floridi, possiamo arrivare lì o quella è solo fantascienza?
[Luciano Floridi]
Se riesco a vedere il volto di una persona cara in una nuvola, lei immagina che non riesca appunto a immedesimarmi con un software che mi parla come se ad esempio fosse una persona cara che è appena dipartita? Questo lo faremo, l'abbiamo già fatto, continueremo a farlo. La vera preoccupazione qui non è tanto che ci sia un software dall'altra parte che sia cosciente … che questa è fantascienza e la lasciamo a Hollywood. La preoccupazione parte nostra è quanto vogliamo essere attenti, attenti a educarci in modo tale che questa non diventi una trappola.
[Rita Cucchiara]
Io penso che un aspetto importante sia il concetto che la Comunità europea chiama di trasparenza, cioè di permettere ad un essere umano di sapere con chi stiamo parlando, se stiamo parlando con la nostra assistente vocale che nel frattempo sta parlando con altre milioni di persone… com'era nel film HER. Oppure invece se stiamo parlando con un essere umano che si avvale di tecnologia, è questo è l'aspetto positivo.
[VOCE NARRANTE]
Qual è il suo rapporto con gli assistenti vocali li usa?
[Rita Cucchiara]
In modo continuo, prima perché funzionano bene, secondo perché mio figlio fa questo mestiere e quindi sono anche mamma e sono molto contenta. E terzo perché io sono anche disgrafica e a volte dislessica e quindi ho assolutamente bisogno di loro per scrivere meglio e per interpretare. Poi mi aiuta in cucina, mi aiuta le poche volte che ci sono, mi aiuta in auto mentre sto guidando e sono ben contenta che le nostre tecnologie servano a qualcosa. La macchina capisce il nostro parlato, capisce le nostre domande e cerca di dare una risposta a questo. Non credo che in questo momento nessuna delle macchine abbia interesse a capire i nostri sentimenti o diventare diciamo come un nostro cane o un nostro gatto che in questo momento hanno una vita molto diversa. È tecnologia, però è tecnologia evoluta.
[VOCE NARRANTE]
Ok Google, mi capisci?
[Google]
A volte non capisco perfettamente, ma cerco sempre di migliorare.
[VOCE NARRANTE]
Questo è Ti racconto l’Emilia-Romagna, il podcast ha cura dell'Agenzia di informazione e comunicazione della Regione. In redazione, Elisa Ravaglia e Agata Matteucci.