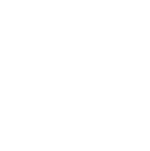Il vostro carcere quotidiano
All’interno dei penitenziari della Dozza a Bologna (852 detenuti, 500 posti) e del Sant’Anna di Modena (576 reclusi, capienza per 372 persone), dove sovraffollamento e autolesionismo minano un già fragile equilibrio di sopravvivenza. Il rosario laico delle richieste di chi è dentro, condannato o in attesa di giudizio, la missione degli educatori e il difficile lavoro degli agenti di Polizia penitenziaria. Il diritto alla salute posto troppo in alto, il reinserimento e un mestiere (per pochi) dietro le sbarre. “Almeno lasciateci la dignità”.
Il racconto di un mondo a parte al seguito delle delegazioni regionali guidate dal presidente Michele de Pascale e dall’assessora Isabella Conti

“Siamo dimenticati da Dio, figurati da voi”. Mano sinistra affondata nella tasca della tuta, mano destra che porta la sigaretta alle labbra, Antonio – lo chiameremo così – alla fine della visita ci saluta con lo sguardo di chi ha semplicemente fatto una constatazione mentre, strascicando le ciabatte, se ne torna verso la sua cella. Anzi, come ufficialmente la chiamano qui, la sua camera.
Questione di forma, cella o camera detentiva, ma anche di sostanza. È proprio negli interstizi di queste differenze infinitesimali che prendono forma le contraddizioni di cui è saturo il carcere, in particolare per chi non ne conosce le dinamiche quotidiane. Quel codice di comportamento non scritto che è poi, in realtà, il libro mastro a cui tutti si attengono, detenuti e agenti di Polizia penitenziaria.
Una zona sfumata in cui tutto trova un equilibrio. Il resto, come dice Antonio, “figurati”.
Ma non è una zona grigia, è un equilibrio di sopravvivenza.
I numeri parlano
Mercoledì 22 gennaio, intorno alle 16, la delegazione regionale guidata dal presidente Michele de Pascale entra alla Dozza. Ci sono anche l’assessora al Welfare, Isabella Conti, il presidente dell’Assemblea legislativa, Maurizio Fabbri, e la vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, accompagnati da rappresentanti della Camera penale di Bologna e del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna.
Una visita istituzionale, la prima di un presidente di Regione alla casa circondariale di Bologna.
L’obiettivo, inforcando le lenti istituzionali, è quello del confronto, delle proposte. Quello più profondo, navigando a vista, è provare a capire. E bastano pochi minuti per avere la certezza che, più entri nel mondo del carcere, meno ne sai. Ma bisogna provarci.
Dopo la parte formale, in cui vengono squadernati i numeri, quel mondo a parte inizia a prendere forma: ci sono 852 detenuti, anche se il carcere è progettato per 500. Ci si deve stringere per forza nelle celle: dove ce ne sta uno – che è la cosiddetta capienza regolare - ce ne devono stare due, quasi in tutte le celle. Dal punto di vista normativo è considerata una capienza tollerabile. Se si passa a tre per cella, cartellino rosso. Sessanta su cento sono stranieri. Trenta su cento sono tossicodipendenti. Cento su cento vorrebbero avere una vita fuori dal carcere.
Di educatori, quelli che incontrano i detenuti per lavorare sulla riabilitazione e sul loro reinserimento sociale, ce ne sono 9. Praticamente uno ogni cento detenuti. Prima del Covid erano 13, di abbondanza di queste figure professionali qui davvero non s’è mai avuto il problema.
Due giorni più tardi, in visita con una delegazione al carcere modenese di Sant’Anna, i numeri puntano il faro su un contesto identico: una capienza di 372 persone, ma i detenuti sono 576. Gli stranieri sono il 66%, i tossicodipendenti il 30%. Gli educatori, 6. E il personale che lavora nelle carceri è sempre insufficiente, perché è rapportato alla capienza ufficiale, non a quella effettiva.
Nelle due carceri, nei primi 20 giorni di gennaio si sono tolti la vita quattro detenuti. E un altro si è suicidato nel carcere di Piacenza. Altri due, poi, hanno dato fuoco alla loro cella e sono ricoverati nel centro ustioni di Parma. E febbraio è iniziato con una nuova tragedia, la morte di un 27enne che era in terapia per la dipendenza da sostanze e per la salute mentale. Una situazione che definire drammatica non è sufficiente, è davvero difficile con le parole della quotidianità comporre un quadro esaustivo. Anche se, per una sintesi brutale, due sarebbero sufficienti: sovraffollamento, disperazione.
Che il carcere sia un posto in cui nessuno sta volentieri – i detenuti di sicuro, ma neanche gli agenti di Polizia Penitenziaria, il cui lavoro è di straordinaria difficoltà e l’abnegazione è ammirabile – è evidente nelle tensioni tenute a freno, nelle dissimulazioni, nell’aria.
Già, l’aria. Quando ci si avvicina all’ala delle sezioni, il microclima cambia. A mezz’aria galleggia, densa e permanente, una nube perenne di fumo di sigaretta. L’odore del carcere è innanzitutto questo, satura l’aria, si attacca ai vestiti, riempie i polmoni, sbiadisce i colori. Ci si fa l’abitudine, per forza.
L’odore stagnante del fumo è il preludio che conduce alle sezioni, il luogo in cui ci sono fisicamente i detenuti, dove ci sono le loro celle, dove vivono 24 ore al giorno al netto di qualche ora d’aria in un cortile da cui si vede il cielo. Arriviamo di fronte a un grande cancello chiuso che separa la zona libera da quella della sezione penale, un lungo corridoio con cancelli che si aprono su decine di celle lungo le pareti. La sezione penale è quella in cui ci sono i condannati in via definitiva, ci spiegano. Quella giudiziaria, invece, ospita i detenuti in attesa del processo.
Si rompe la monotonia
Quando arriviamo, i cancelli delle celle sono aperti, qualche detenuto passeggia nel corridoio. La nostra presenza inizia a destare curiosità, qualche testa si alza a guardare verso di noi, inquadrano una situazione che rompe la monotonia, un diversivo in un pomeriggio identico a migliaia di altri pomeriggi.
Dalle celle escono i detenuti, senza fretta si avvicinano, le loro mani toccano il cancello, si stringono intorno alle sbarre, qualche viso preme tra la inferriate, qualche braccio esce appoggiato sulle barre trasversali del cancello.

Secondo una liturgia non scritta, ma accettata da tutti, è uno di loro che parla per primo, è evidente che è il leader riconosciuto. Chiede chi siamo, anche se è il gioco delle parti, sanno già chi siamo. Quasi tutti i detenuti hanno la sigaretta tra le dita, molti hanno i denti rovinati da vite di tossicodipendenza, occhi che indugiano sui nostri.
Chi ci parla è un detenuto di colore, in un italiano quasi perfetto, che va subito al punto e sgrana, come in un rosario laico, la sequenza di richieste: la difficoltà di iniziare un percorso con un educatore, la possibilità di un lavoro all’esterno, le condizioni igieniche delle docce (che sono solo 3 per 50 detenuti), poche possibilità di chiamare a casa, acqua fredda, caldo d’estate, le sanzioni considerate troppe severe: una litigata con un altro detenuto può comportare il “rapportino”, la cui conseguenza è che saltano i colloqui con i familiari, le telefonate, altri momenti considerati preziosi. Una sequenza di indicazioni che convergono in una sola frase: “Stiamo pagando, ed è giusto, ma fateci stare bene qui dentro. Lasciateci almeno la nostra dignità”.
Mentre lui parla, la riserva del silenzio di tutti gli altri si sfalda, il gruppo non è più compatto, ognuno pensa al proprio destino. Ecco allora che ogni detenuto punta lo sguardo sui nostri occhi, cerca di intercettare una nostra occhiata e, se questo succede, non la molla più e ti attira all’ascolto della propria situazione, dei propri problemi, della propria giornata e della propria detenzione senza mollare mai lo sguardo diretto, che fai fatica anche solo per educazione a non ricambiare. È fondamentale per ognuno di loro trovare in noi un aggancio per provare a portare all’esterno la loro voce, con la loro storia, storia in cui le richieste sono alla fine identiche a quelle di tutti.
Alcuni hanno un rosario tra le mani, altri al collo, altri ancora arrotolato intorno al polso. La dimensione religiosa, complessa fuori, qui assume percorsi intrecciati a un solo tema, quello della speranza: “Aiutate noi, e Dio aiuta da sopra”, ci dicono i detenuti.
Qualcuno prova a passarci un biglietto, nessuno naturalmente lo prende.
Poi il cancello si apre, entriamo, si formano piccoli capannelli in cui ogni detenuto, con le parole, affida la propria storia a qualcuno della delegazione. Gli agenti della Polizia penitenziaria vigilano con una professionalità indiscutibile, quasi invisibili per non interrompere. Il loro è uno dei lavori più logoranti che si possano immaginare, con un immane livello di stress e con tensioni continue, il rischio di burnout è lì a un passo. Anche per questo il turnover tra di loro è altissimo, il ricambio è di circa il 30% del personale ogni due anni, il che mette gli istituti carcerari in una condizione permanente di fragilità su questo fronte.
L’italiano è la lingua ufficiale tra i detenuti, declinata attraverso tanti accenti che spaziano dall’est Europa al Maghreb, allargandosi a tutti i Paesi da cui provengono i detenuti, una cosa che può sorprendere solo chi il carcere non lo conosce, ma certamente non chi ci vive e ci lavora.
Tanto per dare un’idea, una delle competenze richieste per gli psicologi che operano in carcere sono gli elementi di base dell’etnopsicologia, quella disciplina che nell’interazione con i detenuti stranieri diventa fondamentale per poter fare riferimento anche alle caratteristiche morali, mentali e intellettuali dei diversi popoli e delle relative culture. Nell’approccio terapeutico, questo risulta fondamentale per riuscire a entrare nella complessità di ogni identità.
Se nessuno, ma davvero nessuno, dice di essere dentro “per un errore giudiziario”, tutti i detenuti concordano che quello è il posto sbagliato per redimersi, perché quel luogo “è l’università del crimine”, ci dice un ragazzo dell’est Europa: “Io entro per furto, ma quando esco sarò esperto di occultamento di cadavere”.
In attesa di giudizio
Quando diciamo che stiamo per andare nella sezione giudiziaria, dove i detenuti sono in attesa di un processo, un uomo si mette la mano sulla testa: “Di là è terzo mondo”, ci avvisa. Prima di arrivarci, nel corridoio passiamo davanti alle maglie del Bologna appese lungo i corridoi, quella numero 23 di Alino Diamanti e la 33 di Panagiōtīs Kone, ma arriva subito la voce di chi ci attende oltre il cancello: “Venite, qui c’è gli assassini”, in quell’italiano malfermo che è il suono perenne qui dentro, ma che non lascia dubbi di interpretazione.
Poi, come nella sezione penale, quando il cancello si apre, i detenuti si raccontano, e il contesto non cambia: poche ore d’aria, figli piccoli che si vorrebbero abbracciare, lavoro che non c’è.

Segnali di progetti di inclusione e rieducazione, in realtà, ce ne sono: mura della sezione dipinte da detenuti e insegnanti d’arte, riprendendo i reticoli di linee di Mondrian, i riferimenti a Basquiat, il laboratorio culinario per la produzione di caciotte, la biblioteca, le aule. Ma sulle aule si infrange, ad esempio, l’analfabetismo di tanti stranieri, incapaci di reggere il peso anche solo di un’ora di lezione.
Il lavoro è l’orizzonte a cui puntano tutti i detenuti, e le occasioni non mancano. Alla Dozza sono 160 i detenuti che lavorano internamente. Le Acli, per fare solo un esempio, hanno un call center lì dentro, in cui lavorano 12 detenuti che rispondono a quesiti relativi alla provincia di Bologna. 61, inoltre, lavorano in semilibertà per datori di lavoro all’esterno.
Progetti estremamente virtuosi come FDI (fare impresa in Dozza) sono in grado di coinvolgere 15 detenuti. Sono in ogni caso numeri esigui a fronte degli 852 detenuti e, se non si strutturano corsi formativi per numeri molto maggiori di detenuti, quello di orientare alla finalità rieducativa il tempo trascorso all’interno del carcere, rimane un miraggio. La Regione può investire su corsi di formazione strutturati e sul coinvolgimento di imprenditori del territorio. Ed è uno degli impegni presi durante la visita.
Al carcere modenese di Sant’Anna, dove la delegazione guidata da Isabella Conti ha visto la presenza del sindaco Massimo Mezzetti, la vicesindaca e assessora alla Sanità, Francesca Maletti, l’assessora alla Sicurezza urbana di Modena, Alessandra Camporota, e una rappresentanza della Camera penale e del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Modena, le criticità sono le stesse, trasversali al sistema carcerario regionale e nazionale.
Nella sezione in cui è scoppiato l’incendio in una cella, la tensione tra detenuti e Polizia penitenziaria è alle stelle. Gli agenti ci raccontano che i detenuti producono artigianalmente alcolici facendo fermentare la frutta per settimane, intrugli pericolosissimi per la salute e, nel caso specifico, utilizzati anche come carburante per accendere fuochi nelle celle. I due detenuti ospiti di quella cella andata in cenere sono ricoverati al reparto grandi ustioni a Parma, ma a Modena l’odore profondo lasciato dal fumo è ancora nettissimo nella sezione, quasi irrespirabile: “Tanto poi voi uscite a cena stasera, spumante e buona cucina”, ci dice uno dei detenuti.
Alcuni detenuti ci parlano degli scarafaggi, ma c’è un ulteriore problema tipico dei luoghi in cui la promiscuità non è un’opzione, ed è quello delle cimici da letto. Sono insetti che infestano principalmente i materassi e, per debellarli, c’è una sola soluzione: svuotare l’intera sezione in cui si annidano e disinfestare. Per ovvi problemi di capienza non è possibile (dove si possono trasferire i detenuti di un’intera sezione se già c’è sovraffollamento?), quindi si fa a blocchi, a gruppi di 10 o 20 detenuti alla volta, che temporaneamente vengono indirizzati in celle con altri detenuti.
Qualcuno, ci spiegano a Modena, potrebbe chiedersi come sia possibile che dentro alle carceri il 30% dei detenuti sia tossicodipendente, come sia possibile che le sostanze circolino tra le mura delle carceri, ma è una realtà sotto gli occhi di tutto e che nessuno nega. Ha sempre a che fare con la carenza di risorse, ci vorrebbero le unità cinofile permanente agli ingressi. Ma chi se le può permettere?
Anche se per quel tipo di sostanze stupefacenti si è posto un limite, i detenuti si scambiano comunque altri farmaci. C’è un mercato parallelo di farmaci che vengono prescritti principalmente per le dipendenze, che vengono poi scambiati non tanto per lenire gli effetti di una dipendenza, ma per “stordirci”, come dicono nelle sezioni: un surrogato, alla fine, è meglio di niente. Anche per questo, ad esempio, la Regione da qualche tempo ha bandito nel circuito carcerario tutti i medicinali per dipendenza da oppioidi, in modo da stroncarne il mercato illegale. La scelta, come alternativa, è ricaduta su farmaci cosiddetti “in film”, pillole il cui materiale di rivestimento è una pellicola che si scioglie immediatamente al contatto con la lingua e che, teoricamente, dovrebbe azzerarne la possibilità di un eventuale uso successivo.
I risultati ci sono, ma la tossicodipendenza ha anche ulteriori risvolti complessi. Per le persone detenute senza residenza, ad esempio, diventa più complesso il programma di inserimento in struttura residenziale (naturalmente nel caso in cui ci sia una specifica indicazione terapeutica ad attuarlo). I SerDP (Servizi per le Dipendenze patologiche), infatti, hanno maggiore difficoltà a inviare nelle strutture residenziali le persone senza residenza quando escono dal carcere.
Un tema complesso, che si intreccia al tema degli irregolari. Ed è uno dei temi su cui la Regione si è impegnata a trovare rapidamente una soluzione.
Salute!
Ma il tema della tossicodipendenza si inquadra più genericamente nella grande difficoltà dell’azione sanitaria in carcere. Non certo per demerito delle aziende sanitarie, che ne hanno la responsabilità e che assicurano anzi il massimo possibile, ma proprio per le condizioni oggettive.
Il riferimento che ci fanno è chiarissimo: è vero che il diritto alla salute, anche dentro il carcere, è tutelato dalla Costituzione attraverso l’articolo 32, quello che stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Ma il paradosso è che quella sanità – ci dicono - può funzionare fuori dal carcere, non dentro.
Un esempio su tutti è il problema dei denti. Nelle carceri sono tantissimi i detenuti a cui mancano i denti per problemi legati alla tossicodipendenza. E la mancanza dei denti è un moltiplicatore di problemi sanitari, ad esempio per l’alimentazione, per la masticazione, per la postura. Ma i Lea, i Livelli essenziali di assistenza che devono essere assicurati a tutti i cittadini, non coprono i difetti di masticazione, che sono tipici tra i detenuti. Quindi l’indicazione è: mangiati la pastina, che non richiede masticazione. Un ripiego, niente di più. Che fare quindi?
La sanità, sottolineano nelle carceri, è uguale per tutti, ma per le carceri ci vorrebbe un intervento sanitario che innanzitutto porti i detenuti allo stesso livello di salute dei cittadini che vivono fuori e che hanno una condizione sanitaria di base buona e, da lì, applicare i Lea. In sostanza, l’asticella per i detenuti è troppo alta. La sanità in carcere – questo il sentire comune - ha bisogno di una declinazione che vada oltre il concetto “io garantisco dentro quello che garantisco fuori”. Quello che emerge è che bisognerebbe ragionare sul fatto che la presa in carico sanitaria in carcere deve includere interventi che fuori non sono proprio previsti. Il carcere è un contesto societario parallelo, che ha quindi bisogno di una sanità quasi sartoriale, ritagliata sulle esigenze interne. L’asticella è troppo alta, andrebbe abbassata a zero. Il sovraffollamento è sicuramente un problema – su questo tutto concordano – ma non è “il” motivo che scatena i suicidi. Il sovraffollamento è un co-fattore per i suicidi, ma alla base di tutto c’è la condizione di salute, in particolare quella mentale”.
L’obiettivo, al termine del confronto con le amministrazioni penitenziarie, è condiviso: alleggerire il carico di sovraffollamento, anche senza strumenti come amnistia o indulto, è possibile. La parola chiave è “inclusione”: il carcere può essere una risorsa per il territorio perché toglie un pericolo dal contesto della quotidianità, ma il cerchio si chiude solo se quella persona rientra in modo virtuoso e diventa una risorsa positiva.
Tanto si fa (lo raccontiamo in altra sezione di questo speciale) e tanto c’è ancora da fare, proprio per garantire ai detenuti e a tutto il personale che lavora nelle carceri, Polizia penitenziaria in primis con il loro carico di lavoro complesso e logorante, il pieno appoggio delle istituzioni. E provare a dare torto ad Antonio e alle sue parole di commiato: “Siamo dimenticati da Dio, figurati da voi”.
Testi a cura di Stefano Aurighi
Foto 1 e 3 di Francesco Cocco, rielaborazione grafica di Cristina Gaddi
Foto 2 fonte Pixabay